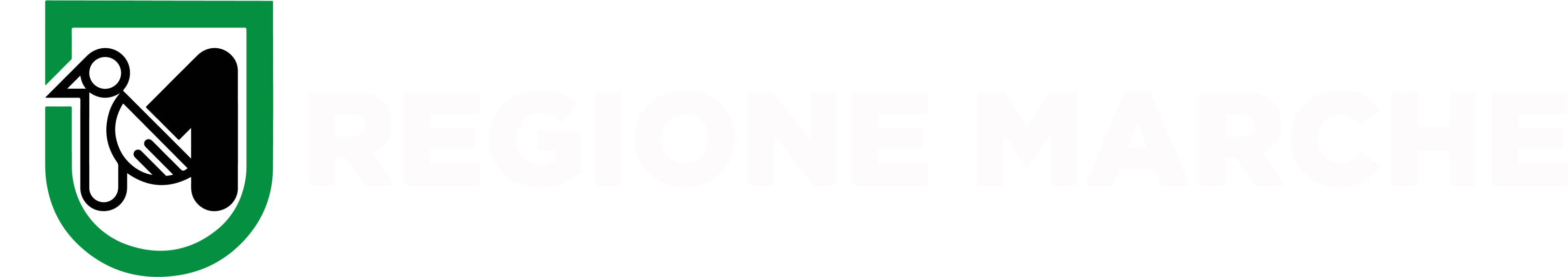RELIGIOSITA’ E SPIRITUALITA’
Il nostro territorio è ricco di tradizioni, ricorrenze, memorie che si perdono lontano nei tempi antichi, ma che ancora oggi, in alcuni particolari momenti dell’anno, o in alcuni luoghi ricchi di spirito e significato, mettono in stretto contatto l’uomo con la sua personale spiritualità
In questa pagina abbiamo raccolto alcune delle manifestazioni a carattere religioso più significative del nostro territorio, che hanno nel Venerdì Santo il loro culmine, e inserito alcuni dei numerosissimi luoghi di interesse spirituale sparsi tra le nostre valli e le nostre montagne.
Eventi Religiosi
La Turba di Cantiano

Il Venerdì Santo che precede la Pasqua, ogni anno in questo paese è un vero e proprio “turbinìo” di sensazioni, ci si ritrova immersi in un altro spazio-tempo, dove si può vivere un’esperienza sia da fedeli sia da spettatori laici. “La Turba”, ormai da 500 anni, coinvolge tutto il centro storico di Cantiano che diventa un grande teatro all’aperto con elementi scenografici architettonici e orografici, figuranti in costume, suggestioni visive, sonore e spirituali. Tutti gli abitanti del borgo, dai giovanissimi ai più anziani, partecipano a questa manifestazione che è percepita come parte della loro storia e delle loro radici. Con il chiarore dell’alba alle 05:30 si inizia il giro delle sette chiese di Cantiano, da qui il percorso si snoda tra i luoghi simbolici della processione. Ci si sveglia tra canti e preghiere e al suono della “battistangola”, uno strumento realizzato con una tavola di legno sulla quale è inserita, da ciascun lato, una maniglia rotante in ferro che colpisce alcune piastre producendo un suono inconfondibile. Ma questo è solo il risveglio, perché il lungo Venerdì Santo a Cantiano prosegue con l’azione liturgica della Passione di Cristo scandita dai rintocchi di quattro chiese che accompagnano la processione del Santissimo Crocifisso e della Madonna Addolorata fino al colle di S. Ubaldo.
La Passio di Serravalle di Carda

La sacra rappresentazione della Passio di Serravalle di Carda è organizzata in una serie di tappe o “stazioni” direttamente riprese dai racconti evangelici. Si ripercorrono così gli episodi della “Via Crucis” che segnano le celebrazioni del Venerdì Santo in tutti i paesi di tradizione cattolica. L’itinerario parte con l’Ultima cena e la lavanda dei piedi, episodio che tradizionalmente segna l’avvio della Passione di Cristo, la tappa successiva è quella nell’Orto degli ulivi dove Gesù viene arrestato dopo il bacio dell’apostolo traditore Giuda. Quindi si passa al palazzo del sommo sacerdote Caifa dove Gesù viene interrogato e processato dal Sinedrio. Ci si trasferisce poi nella sede del governatore romano Ponzio Pilato dove Gesù viene nuovamente interrogato, con gli episodi della flagellazione, la lavanda delle mani di Pilato e la liberazione di Barabba a furor di popolo.
Inizia poi l’ascesa al Calvario con Gesù sotto il peso della croce, un cammino di dolore e sofferenza che si conclude con la Crocifissione, momento di estrema commozione, rappresentato con estrema forza drammatica. Gli effetti sonori e visivi rendono estremamente coinvolgenti gli ultimi momenti della vita di Cristo, con una grande partecipazione del pubblico che nel proprio intimo riesce a rivivere la morte di Gesù. Una particolare caratteristica della Passio di Serravalle di Carda è l’animazione di tutti gli angoli del paese con una serie di scene di vita quotidiana del tempo. Sono angoli tipici dove altri figuranti, oltre quelli impegnati nella rievocazione degli ultimi momenti della vita di Gesù, ricreano situazioni di un passato lontano, con costumi e ricostruzioni sempre curatissimi. Le scene ricostruite sono diverse e tutte di grande fascino e suggestione. Si va dal lavoro della “Donna al telaio” alla bottega del “Falegname”, al momento familiare della “Donna che fila la lana con bambini”. Si passa poi alla ricostruzione di un’antica “Osteria” alla scena più grande dell’intera rappresentazione, un “Mercato” ricchissimo di particolari e ambientazioni. Non mancano il “Forno”, la bottega del “Fabbro Maniscalco” e la “Donna al setaccio”. Altre scene sono quella della “Famiglia” con una donna e i suoi bambini, quella dei “Pescatori” e l’angolo riservato alle “Lavandaie”. Sono ricostruzioni che vanno a comporre una sorta di “teatro dei mestieri e delle scene di vita” che proietta il pubblico nel passato e da il senso di un’intera società coinvolta nelle vicende della Passione di Cristo.
Processione del Cristo Morto a Cagli

Organizzata dalla Confraternita del S.S. Crocifisso e di San Giuseppe che invita le altre quattro confraternite cittadine: la Confraternita della Misericordia, la Compagnia della Buona Morte e Orazione, la Confraternita degli Artieri e la Compagnia della Madonna del Buonconsiglio. Quando nel ’500 Cesare Borgia entrò in Cagli, dicendo che avrebbe invaso il ducato di Camerino, in realtà voleva occupare le terre del Ducato di Urbino fino a Cesena, per realizzare un grande stato nel centro Italia. I cagliesi si ribellarono subito a queste sue intenzioni e ben 11 ragazzi vennero impiccati alle caditoie del Torrione. Il vescovo di Cagli Gaspare Golfi andò a protestare ma, minacciato di morte, scappò verso Pergola e venne ucciso a San Savino. I cagliesi, in seguito, riuscirono a scacciare gli spagnoli che lasciarono in città un Cristo in legno di fico, vuoto al suo interno e con braccia mobili, con sembianze tipiche spagnole. Era stato utilizzato dal Borgia per entrare in città e ingannare gli abitanti sulle reali intenzioni di quest’ultimo. I cagliesi per celebrare la liberazione dagli spagnoli idearono questa processione che inizialmente vedeva la contrapposizione fra la Confraternita di San Giuseppe e la Compagnia della Madonna del Buonconsiglio per decidere chi l’avrebbe organizzata. Le varie confraternite sono strutturate in modo particolare: ognuna ha il suo Primo Priore (una sorta di presidente) e gli Officiali (consiglieri); inoltre è presente il Camerlengo (cassiere) e il segretario. Il Mazziere Capo (detto anche ‘Mazziere volante’) appartiene alla sola Confraternita di San Giuseppe e si occupa del buon andamento della processione, mentre ogni altra confraternita ha un semplice Mazziere. Altre due figure particolari ed entrambe ereditarie sono il Priore responsabile della custodia del Cristo, e il Priore responsabile del carro (risalente al 1700 e formato con aste mobili che sostengono il baldacchino per divincolarsi al meglio fra le strette vie del centro) il quale si occupa di montarlo e smontarlo tutti gli anni. La particolarità di questa processione è che viene svolta a piedi nudi come da tradizione, scalzi in segno di penitenza ed incappucciati perché la penitenza è un gesto di intimità e non deve essere manifestata al di fuori.
LUOGHI DI SPIRITUALITA’
Monastero di Fonte Avellana

ll Monastero di Fonte Avellana è situato alle pendici boscose del Monte Catria a 700 metri sul livello del mare. Le sue origini si collocano alla fine del X secolo, intorno al 980, quando alcuni eremiti scelsero di costruire le prime celle di un eremo che nel corso dei secoli diventerà l’attuale monastero. La spiritualità di questi eremiti fu influenzata da San Romualdo di Ravenna, padre della Congregazione benedettina camaldolese. Egli visse e operò fra il X e l’XI secolo in zone vicinissime a Fonte Avellana, quali Sitria, il monte Petrano, e San Vincenzo al Furlo.
Molte delle consuetudini eremitiche avellanite erano pressoché identiche a quelle in uso all’Eremo di Camaldoli e in altri luoghi romualdini ed anche la Regula vitae eremiticae scritta da San Pier Damiani per Fonte Avellana ha molti elementi in comune con le Constitutiones del Beato Rodolfo, IV priore di Camaldoli.
Lo sviluppo di Fonte Avellana iniziò con San Pier Damiani, alla cui forte personalità si devono non solo il nucleo originario della costruzione, ma più ancora l’impulso spirituale, culturale e organizzativo che resero l’eremo centro d’attrazione e di diffusione della vita monastica e che influirono fortemente sulla riforma religiosa e sulla vita sociale. Grazie a questa figura eccezionale di monaco e di uomo di chiesa, il monachesimo avellanita e camaldolese ha potuto presentarsi, nella sua storia pluricentenaria, come esperienza qualificata del cristianesimo. In questo eremo, infatti, si formarono circa cinquanta vescovi e un folto stuolo di monaci noti per santità e dottrina.
Una tradizione costante e molto antica vuole che anche il Sommo Poeta Dante Alighieri sia stato ospite di questo monastero che cantò nella Divina Commedia:
“Tra due liti d’Italia surgon sassi,
e non molto distanti a la tua patria,
tanto che i troni assai suonan più bassi,
e fanno un gibbo che si chiama Catria,
di sotto al quale è consecrato un ermo,
che suole esser disposto a sola latria”
Secondo gli Annales Camaldulenses Dante nel 1318 era ospite di Bosone di Gubbio e in quell’anno sarebbe venuto a Fonte Avellana.
Eretta abbazia nel 1325, Fonte Avellana divenne una potenza socio-economica e, di lì a poco (1392) conobbe la pratica delle commende (XIV – XV sec.). La commenda consisteva nell’affidamento dei benefici o dei beni di proprietà di un monastero o di un’abbazia a persone estranee, per lo più di alto rango ecclesiastico o civile, al solo scopo di far la fortuna di queste. Per tale motivo la commenda è considerata una piaga, una di quelle disgrazie che contribuirono moltissimo alla decadenza morale, oltre che materiale, di moltissimi centri monastici. Fonte Avellana restò “commendata” fino a quasi tutto il 1700 ed anche se ebbe dei commendatari come, per esempio, il Card. Giuliano della Rovere poi Giulio II, che lasciarono segni di carattere edilizio ed abbellimenti del tutto degni di nota, nondimeno risentì profondamente degli inevitabili condizionamenti, motivo per cui la decadenza della sua vita monastica, anche se lenta, fu inesorabile.
Tale declino si concluse con la soppressione napoleonica del 1810 e di lì a poco quella italiana del 1866. Fonte Avellana, tuttavia, ha continuato a vivere come alimentata da una sorgente interiore ed oggi, tornata ai monaci camaldolesi, ha ritrovato oltre alla bellezza austera delle sue strutture architettoniche, ormai interamente riportate alla loro bellezza primitiva, anche quella fede e quella cultura che l’hanno contraddistinta fin dalle sue origini.
Santuario del Pelingo

Alle falde del Pietralata, sorge il Santuario della Madonna della Misericordia del Pelingo. Di antica origine, la piccola chiesa, ampliata poi nel secolo scorso, con il dipinto della Madonna, fu voluta nel XIV sec. dalla famiglia Pelingo, possidente di terreni in quel luogo. Essendo diminuita col tempo l’attenzione dei fedeli nei confronti dell’immagine della Vergine, l’oratorio fu gradualmente abbandonato e dimenticato. Un grande risveglio di venerazione si ebbe a partire dal 1781 quando, a seguito di un forte terremoto, si decise l’abbattimento dell’edificio che era stato gravemente danneggiato; infatti, tornata alla luce l’immagine originaria della Madonna che era stata ricoperta da un altro dipinto, alla stessa furono attribuite alcune miracolose guarigioni; pertanto fu necessario edificare una cappella per proteggere l’immagine ed ospitare le folle di pellegrini che invocavano la Vergine col nome di Madonna della Misericordia.
L’edificio attuale fu iniziato verso il 1820 e consacrato nel 1859. Il dipinto della Madonna, restaurato nel 1981 e di autore ignoto, è posto sopra l’altare maggiore e protetto da una bacheca di vetro. Nelle due cappelle laterali sono ospitati da un lato il dipinto dedicato a S. Michele Arcangelo e dall’altro quello della Madonna del Rosario, opera di Girolamo Cialdieri.
Ogni anno, l’otto settembre, in questo santuario viene celebrata la festa della natività della Madonna. Annessa alla chiesa è la struttura ricettiva “Casa del Pellegrino”.
Convento Padri Cappuccini a Cagli

Il Convento di Cagli è considerato da più parti come uno dei più insigni fra tutti i conventi delle Marche, per antichità e stile: che sia genuinamente cappuccino lo si nota nella spiccata povertà e nell’ elegante semplicità delle forme.
Il convento è composto da una struttura quadrangolare con al centro un cortile, dove è collocato un pozzo che corrisponde, come detto in precedenza, al primo referto della rocca, situato sotto il mastio, occupato ora dalla chiesa. L’ala est del convento, rivolta verso la città, è in parte un riuso della vecchia rocca. Infatti, nelle cantine che i frati chiamano “Grotte” sono ancora visibili rimanenze della vecchia costruzione martiniana, come il forno utilizzato per scaldare acqua ed olio da gettare contro i nemici, modificato poi nel tempo dai frati per i propri usi.
Anche il refettorio si pensa che fosse parte della vecchia rocca. Esso è situato nell’ala sud, al primo piano del convento, piano adibito alle attività giornaliere. Nel secondo piano sono situate le piccole celle per i frati. Sono ambienti molto umili, arredati solamente da un letto, una scrivania e un lavabo. In questa zona è collocata anche la biblioteca, comprendente diversi libri stampati, anche antichi.